Parte integrale del ministero Camilliano è l’assistenza ai moribondi nelle case private. Durante tutto il secolo XVII, specialmente, un tal ministero assunse proporzioni così vaste e così alte da meritare ai Camilliani il simpatico titolo di Padri della Buona Morte, e del Bel Morire. In Sicilia passò in preverbio: «Sei insistente come un Crocifero al letto d’un moribondo». Otto Cima ha di dichiarato che, a Milano, «bastava aver una mezza intenzione di morire» per trovarsi un Camilliano in capo al letto.
Il Card. Federico non interdisse un tal ministero ai Camillini: piuttosto, costoro, non vi si poterono applicare, fino al 1630, che in proporzioni ridotte per il gran lavoro che avevano all’Ospedale e per l’abitazione, troppo ristretta, dell’Annunziata dove s’adattavano a restare con gran sacrificio e in numero troppo limitato, rispetto al bisogno, e cioè alle richiese che loro venivano fatte da ogni parte della città.
Contuttociò non meno di quindici Religiosi erano, ordinariamente, a disposizione per l’assistenza ai moribondi nelle case private. S’alternavano coi venticinque dell’Ospedale facendo in turno con loro, due o tre settimane, nel Pio Lungo ed una in casa religiosa. Tali erano state le disposizioni del Fondatore, sanzionate dalla S. Sede.
Al sopraggiungere della peste tutte le risorse e tutte le attività furono chiamate in esercizio, non solo, ma poste addirittura allo sbaraglio. «Opere e carità – pareva ripetesse ai suoi Figli il Fondatore S. Camillo, che tutti quasi avevano conosciuto – opere e carità vuole adesso da noi» il Signore e la società. E scesero generosi in campo. Quelli dell’ospedale non accettarono più cambi, ma solo sostituzione in caso di morte di qualche confratello. Quelli di città si divisero: alcuni al Lazzaretto di S. Barnaba, altri un po’ da per tutto, e cioè dove maggiore era il bisogno.
Fra Filippo Visconti, Priore del Convento di S. Marco – testimonio di quanto accadde in Milano, in quel fortunoso anno 1630 – ci lasciò una lusinghiera testimonianza in favore dei Camilliani – osiamo almeno supporlo, chè, se non ne fa il nome, li individua per il ministero loro proprio – «Piissimi Religiosi, qui curam infirmorum et decedentium mira charitate desumeabant…».
Non vogliamo, del resto, arbitrarci tanto onore che può essere, a buon diritto, comune con tutti i Religiosi.
Il Card. Federico – dice infatti un’altra cronaca – «diede licenza a molti religiosi di andare per la città a compiere il pietoso ufficio di assistere i moribondi: ottenne, anzi, dal Sommo Pontefice, un giubileo per tutti quei sacerdoti e Religiosi che avessero amministrati i SS. Sacramente agli infetti».
Il Ripamonti lasciò scritto: «Bello (era) vedere i Religiosi, (nomina in particolare i Domenicani, i Teatini, i Minori= frammisti ai Parrochi, gareggiare nella gloriosa lotta contro i pericoli e la morte! Bello e consolante, in mezzo a tanto lutto, vedere i parroci raddoppiare gli sforzi per uscir vincitori, e se pure venivano da zelanti Religiosi superati, andarne lieti come d’un loro trionfo…
«Frati e sacerdoti battevano alle porte, salivano con scale alle finestre, recando seco vivande e distribuendole con pronta e fervosa carità».
In tal plebiscito di carità raccogliamo in particolare – come ci siamo proposti – la voce del «cuore e dell’opera» dei Camilliani.
Chi si distinse più di ogni altro, nell’assistenza degli appestati in città, fu il Superiore stesso della Comunità Religiosa Camilliana, il p. Giuseppe Belcastro.
Il nostro cronista ci ha lasciato di lui un elogio che – pure nello sfarzo dei letterari paludamenti secentisti – ci fa gustare la «forza viva, propria e per dir così, incomunicabile» dello spirito generoso di tal superiore. «Un colosso – dice lui – che, pur sepolto in una profonda cisterna, ha conservata la sua grandezza». Un uomo – intente dire – che poteva eccellere nella scienza, specie del diritto, e si accontentò di restarsene umile e nascosto facendo balenare, appena quando n’era pressato, i lampi del suo genio particolare.
Il più bel elogio, del resto, è l’essere stato un «uomo di molta orazione, unione con Dio… e aver dato saggio d0animo invitto nelle case… di servitio di Dio, e utile del prossimo, massime infermi». Per la «sua bontà e mansueta destrezza» non trovò chiusa mai alcuna porta, ch’era anzi ammesso anche dove gli altri suoi Religiosi «erano assolutamente esclusi».
Il p. Belcastro, amatissimo dai suoi Religiosi, stimato da molti, desiderato e invocato dagli Infermi, assomigliava un capitano alla testa d’un manipoli di eroi. Con il suo esempio, con il suo consiglio, con il suo comando era da per tutto: all’Ospedale, al Lazzaretto, nelle case dei cittadini, ovunque la sua presenza fosse necessaria, richiesta o anche semplicemente desiderata.
Tanto fervore e tanto sacrificio non lo risparmiò a lungo. Contrasse la peste. Domo ma non ancora vinto, chiamò i Religiosi della casa intorno al suo letto; dètte consegna di tutto ciò che aveva in custodia, che lasciava in sospeso, che teneva in progetto e volle che tutto fosse posto in carta. Poi, da valoroso capitano, esortò i suoi figli a perseverare con santa fortezza nel buon combattimento ricordando che, in quella trepida ora, non potevano ripromettersi – come Dio concedeva a lui – gloria più grande del morire «con le armi in pugno» servendo cioè «i poveri infermi».
Ai confratelli che stavano in Ospedale e al Lazzaretto fu dato avviso, dell’aggravarsi del Padre, così: «Molto Rev.di in Cristo Padre – Pax Cristi – Saluto caramente le P.P. (Paternità) et R.R. (Reverenza) vostre et insieme dannoli parte come il nostro Padre Prefetto alli 21 del stante (Giugno) si è posto in letto con febre, et nella quarta si gli è scoverto la peste, con essergli dato fuori il bonmone (bubbone): già ha preso il Viatico et l’Oglio Santo et temiamo che questa notte prossima futura passerà da questa a miglior vita».
Morì – difatti – la stessa notte o al più tardi quella appresso e ne troviamo l’atto di morte nei registri del Lazzaretto di S. Gregorio: «Giorno ventesimosettimo del mese di Giugno. R. Sacerdote Belcastro, d’anni 62, morto di peste a giudizio del Rossore fisico collettore».
La perdita del Padre e della guida – di tal Padre poi e di tal guida – nell’ora del maggior bisogno, dovette dar luogo ad un momentaneo smarrimento di quei suoi Religiosi. Del resto erano abbastanza addestrati a quel duro cimento, e l’eredità di tal Padre suonava al loro cuore «promessa di vita e di gloria nella morte». Altro non si ripromettevano.
Al Superiore tenne dietro, un mese dopo, il p. Francesco Antonio d’Agostino. Anche l’apostolato di costui fu di preferenza, al letto dei moribondi nelle private abitazioni dei cittadini. Stette per alcun tempo, al Lazzaretto di S. Barnaba 8probabilemten a supplirvi il P. De Caro nel tempo che questi ebbe la peste) e ritornò poi al suo vastissimo campo di lavoro con zelo e carità grande. Dopo aver «per buon spazio (di tempo) ministrato i SS. Sacramenti», contrasse la peste. Premunitosi, con pietà e fervore, di quei celesti conforti che aveva egli stesso procurati con carità e tantissimi altri, «con atti di perfetta religione» si fece incontro a quella morte «molto più invidiabile che invidiata» alla quale s’era preparato come a un premio.
Ma la figura più caratteristica, diremo così, resta quella del fratello Olimpio Nofri. Il nostro Cronista stinge tutta la sua tavolozza a ritrarre quest’umile e grande eroe. Ne richiama anzitutto, la nobiltà del casato, in Siena, sua patria: poi la modestia, l’amore al silenzio, lo spirito di penitenza, lo zelo per la salvezza delle anime, la illuminata carità nell’assistenza degl’infermi, questa, soprattutto questa, che gli fece preferire ed elegere nella Religione, lo stato di semplice fratello, per esercitarvisi a maggior talento.
Nella virtù dela carità per gli infermi il Nofri, veramente ebbe un ammiratore ed un giudice di ben altra portata del nostro Regi; lo stesso S. Camillo de Lellis. Il 3 Dicembre 1608, il Santo stava in Genova ed era stato informato che il Padre Sorrentino, Superiore di Milano, intendeva levare, dall’ufficio «d’infermiere maggiore» nell’Ospedale, il Nofri per adibirlo alla questua delle elemosine, in considerazione degli eccezionali bisogni ne’quali versava la Comunita.
Camillo scrisse, in data di quel giorno, due lettere: una al Padre Sorrentino e un’altra al Fratel Nofri. Consiglia (non era più superiore il Santo) consiglia, ma con autorità, il Sorrentino «a non dar orecchio ad alcuno» e che, per «gloria di Sua Divina Maestà, per edificazione della nostra Religione et per beneficio di quelli poverelli infermi» e, perfino «per discarico della (sua) coscienza», lasci il Nofri al suo posto di «infermiero generale» perché è uno di quei pochi uomini de’quali su può dire: «uno vale mille» ed «è ottimo» in quell’ufficio. Al Nofri – contemporaneamente – scrisse di rimaner nell’Ospedale col suo impiego «molto volentieri», che egli stesso «molto glielo desiderava» e che «molto l’avrebbe avuto caro» se così fosse stato deciso.
Quando ne fu certificato ne provò «molto contento» e riscrisse: «Il Signore ne sia lodato e servito per mezzo di questi poverelli membri di Cristo. Attendete, fratello mio, alla (loro) cura con ogni diligenza e fate dal canto vostro (che non manchino) di niente, sì nelle cose spirituali come corporali, di giorno, come di notte».
Non farà meraviglia, dunque, che un Religioso, il quale aveva meritate tali commendatizie, abbia potuto e voluto sacrificarsi fino al punto e nella maniera che stiamo per dire.
Il Fratel Nofri, sul principio del 1630, era occupato nella questua. Né c’è ragione di mostrarsene sorpresi, conoscendo l’espresso desiderio del Fondatore che, il buon fratello, rimanesse piuttosto in Ospedale. Non si deve dimenticare, anzitutto, ch’erano passati 22 anni e il Fratel Nofri era poco meno che interamente consunto dalle fatiche dell’Ospedale: il Regi stesso, poi, dice chiaro la seconda ragione. Nessun altro religioso camilliano, dopo gli avvenimenti intercorsi, poteva attendere a quella cura, con la grazia di lui che otteneva i soccorsi della terra, chiedendoli solo, con parlare delle cose del cielo e con la sua modestia.
Non appena il contagio si rese manifesto, il buon Fratello – nonostante il peso degli anni e degli acciacchi – si fece innanzi a chiedere la sua parte di fatica e di meriti. Lasciò la questua e rientrò nell’ufficio di capo infermiere all’Ospedale, al posto di Fratel Terzago che passava al Lazzaretto di S. Barnaba.
Infermiere-apostolo, nel concetto sublime del Fondatore S. Camillo, cresciuto, anzi, e formato alla sua scuola, era tutto ardore nel prodigarsi agli infermi. Risorse fisiche, intellettuali, spirituali tutto metteva a mirabile profitto di causa tanto sublime.
Serviva agli infermi col rispetto e con l’amore col quale si serva a Dio e nello stesso tempo apriva la via alla grazia e all’amore di Dio nel cuore degli infermi. Li esortava alla pazienza, alla penitenza, sapeva insinuarsi con tanta efficacia che, no raro, di rivoltosi, d’insofferenti, di peccatori induriti, riusciva a far degli apostoli della sofferenza, delle vittime volontarie per i peccati propri e per quelli del Mondo.
Ricco di tanti e di sì felici acquisti vide, con animo sereno, avvicinarsi l’ora sua. Prima la febbre, poi un bubbone e alcune pustole, «araldi di morte», lo misero sull’avviso di quel che era, e conosceva troppo bene, la peste.
Si licenzio dall’Ospedale, dove non poteva più stare senz’essere di pericolo agli altri, e si portò «al quadrone» a porta Ludovica (l’attuale via Quadronno) dove i Padri Camilliani avevano avuto in dono da Mons. Besozzo una casa di campagna che serviva loro, tra un periodo e l’altro di dimora nell’Ospedale.
Al diffondersi del contagio, d’accordo con l’amministratore dell’Ospedale Maggiore, che li provvedeva del necessario, i Padri destinarono quella casa a rifugio dei Confratelli che avessero contratta la peste, denominandola per tal ragione – in seguito – la «Casa della morte».
Fratel Olimpio Nofri, prima che gli mancassero interamente le forze, si presentò con le migliori disposizioni a ricevere i SS. Sacramenti, poi venne a rinchiudersi in questa casa. Era stata aperta – nel giardino di essa – e si teneva a disposizione, una larga fossa, per seppellirvi quei Religiosi che la pesta dava in braccio alla morte. Il Fratel Nofri si eresse, a capo di quella fossa, una capanna: poi passandosi attorno la cintola una corda ne fissò l’altra estremità, alla parte opposta della buca, ad un pilastro della casa. Alla sua morte, i Religiosi Confratelli, dando uno strappo alla corda, potevano far cadere – senz’altro incomodo – il cadavere nella sottostante buca, aspergerlo d’acqua santa, recitare qualche preghiera e ricoprirlo pietosamente di terra.
I Confratelli quando videro e intesero tutto questo, ne provarono ribrezzo e n’ebbero gran dolore: non volevano, a nessun patto, permettere che un uomo, vecchi, di tanti meriti, morisse abbandonato a quel modo. Ma non ci fu verso di smuoverlo dal suo proposito. Rispose che cos’ stava bene ed era il meglio che si potesse fare per lui: lasciarlo morire senza che, per aiutarlo nei suoi bisogni, altri infermi mancassero di aiuto, ed altri Confratelli si esponessero al pericolo di prendere la peste.
Cosi volle così fu. Raccolto in amoroso colloqui col Crocifisso, che teneva tra le mani, attese la morte la quale non tardò molto a schiudermi, pietosa, la porta del cielo.








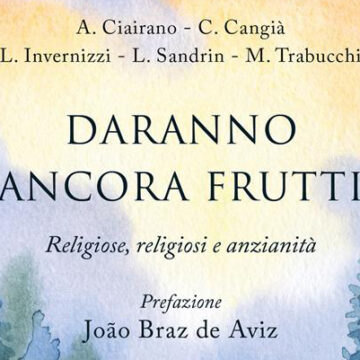








I Camilliani su Facebook
I Camilliani su Twitter
I Camilliani su Instagram